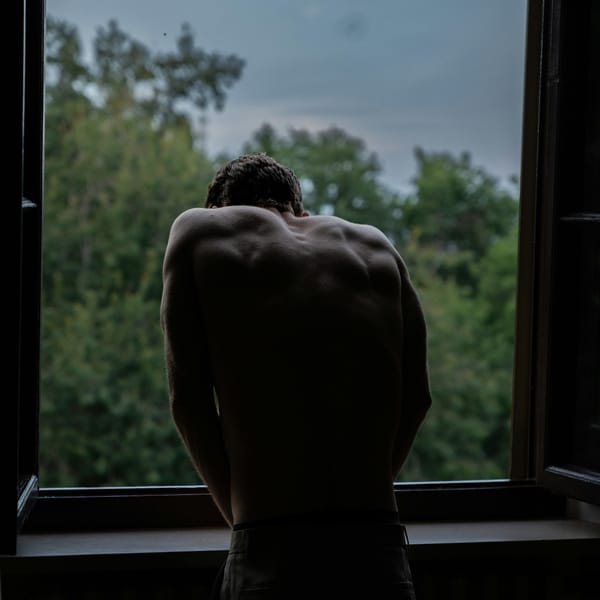L’essere umano è oggi così distante dal naturale processo fisiologico dell’enterocezione1 da rendere complessa persino la sua descrizione. Negli altri mammiferi l’organismo è il fondamento sensoriale dell’esistere: il corpo sente, regola, decide. Nell’uomo questo legame è stato progressivamente allentato: lo sviluppo individuale richiede presto una scissione dalle funzioni giudicate “indesiderate” (impulsi, emozioni, posture, desideri), per aderire a sistemi di regole e riconoscibilità sociale.
L’essere umano è oggi così distante dal naturale processo fisiologico dell’enterocezione Nota 1 da rendere complessa persino la sua descrizione. Negli altri mammiferi l’organismo è il fondamento sensoriale dell’esistere: il corpo sente, regola, decide. Nell’uomo questo legame è stato progressivamente allentato: lo sviluppo individuale richiede presto una scissione dalle funzioni giudicate “indesiderate” (impulsi, emozioni, posture, desideri), per aderire a sistemi di regole e riconoscibilità sociale.Famiglia, scuola, lavoro e comunità veicolano limiti e credenze che orientano il comportamento molto prima che si formi una competenza nel sentire. L’emancipazione che rivendichiamo sul piano culturale appare spesso esteriore: le forme cambiano, ma sotto la superficie persistono convinzioni profonde su sessualità, potere, appartenenza, paura, rispetto, amore, efficienza. Queste credenze trattengono l’organismo in uno stato di iper–controllo e di ipo–sensibilità. (La malattia, che può ostacolare l’enterocezione in modi specifici, merita un trattamento a parte.)
Malattia come conseguenza di un corpo abbandonato
Le innumerevoli malattie che affliggono oggi il genere umano non sono altro che la conseguenza dolorosa di un corpo abbandonato, che non sa più autoregolarsi né fluire secondo i principi fisiologici che lo hanno guidato per centinaia di migliaia di anni. Quando il corpo perde la capacità di riconoscere i propri segnali interni e di modulare in modo ciclico tensione e distensione, attivazione e riposo, si disorganizza in ogni sua funzione vitale. La sofferenza psichica e fisica che dilaga nella nostra specie non è quindi un insieme casuale di patologie, ma il sintomo globale di una disconnessione sistematica dalla fisiologia enterocettiva.
Cosa intendiamo per “sentire” e per “essere”
- Sentire: è l’atto di portare attenzione ai segnali interni (respiro, battito, tensioni, viscere, emozioni). È un’operazione percettiva e attentiva, spesso intermittente, che produce contenuti di esperienza.- Essere: è lo stato integrato in cui quei segnali non sono più “oggetti” che osservo, ma processi che mi costituiscono. Qui i segnali interni modulano postura, tono, azione, linguaggio, scelta; regolano i cicli naturali di attivazione/riposo (il Codice Bipolare Nota 2), e sostengono un senso di identità incarnata.
In breve: il sentire apre la porta; l’essere è l’abitare. Ridurre l’enterocezione a un “esercizio” rischia di mantenerla come tecnica esterna al Sé; integrarla, invece, restituisce regolazione (autonomica, motoria, affettiva) e direzione all’organismo.
Perché il “benessere” resta spesso superficiale
L’offerta crescente di pratiche somatiche, psicologiche e olistiche invita all’ascolto e alla consapevolezza, ma rimane perlopiù nel registro del problema individuale: “io ho un disturbo e scelgo una via naturale invece del farmaco”. Raramente terapeuta e cliente riconoscono che stanno incontrando una condizione della specie, non un’eccezione personale. Così persiste un’idea di normalità apparente3: ci si dichiara “a posto” pur convivendo con nevrosi, tensioni croniche e scompensi funzionali.
L’offerta crescente di pratiche somatiche, psicologiche e olistiche invita all’ascolto e alla consapevolezza, ma rimane perlopiù nel registro del problema individuale: “io ho un disturbo e scelgo una via naturale invece del farmaco”. Raramente terapeuta e cliente riconoscono che stanno incontrando una condizione della specie, non un’eccezione personale. Così persiste un’idea di normalità apparente Nota 3 : ci si dichiara “a posto” pur convivendo con nevrosi, tensioni croniche e scompensi funzionali.Dalla pratica del sentire al ritorno all’essere: un modello operativo
Un percorso possibile va inteso come processo naturale e graduale di integrazione e identificazione, che si svolge ciclicamente e in modo sempre più spontaneo e naturale. Non è una tecnica da imparare, ma un ritorno a una competenza fisiologica sopita.
- Orientamento & SicurezzaStabilire punti di riferimento corporei stabili (appoggi, peso, respiro basso) e ambientali (luce, spazio, temperatura). La sicurezza percepita è la premessa della sensibilità.
- RilevazioneRiconoscere segnali interni senza giudizio: ritmo respiratorio, ampiezza, micro–tensioni, pulsazioni, motilità viscerale, emozioni emergenti.
- StabilizzazionePermettere ai segnali di durare senza fuggire né forzare: tolleranza graduale, modulazione dell’intensità (titolazione), alternanza contatto–pausa (pendolazione).
- SignificazioneCollegare i segnali a postura, gesto, linguaggio, relazioni. Qui il corpo smette di essere “contenuto” da osservare e diventa criterio: influenza scelte e confini.
- Integrazione identitariaLa pratica non resta “ciò che faccio” ma diventa ciò che sono: i cicli del Codice Bipolare (attivazione/riposo, espansione/ritiro) tornano a scandire tempo, energia, lavoro, affetti. È il passaggio dal sentire la tristezza all’essere in un modo che include quella tristezza e la sa regolare.
N.B. Il processo di rientro verso l’enterocezione tende inevitabilmente a riattivare la paura del giudizio Nota 4 : la stessa che, fin dall’infanzia, ci ha spinto a smettere di sentire per adattarci. Ogni soglia enterocettiva riporta alla superficie quel timore, che siamo chiamati a riconoscere e trasformare. La differenza è che oggi possiamo attraversarlo con il supporto delle esperienze precedenti e con una autostima più matura, capace di sostenere l’integrazione di ciò che un tempo è stato escluso.
Etica del corpo: responsabilità, non prestazione
L’enterocezione non può essere solo “alternativa” alla medicina o abitudine igienica per conservare la salute. È un atteggiamento: una forma di responsabilità verso se stessi e verso gli altri, perché un corpo che sente regola la propria forza, non la scarica; riconosce i limiti, non li sposta sugli altri; sceglie secondo cicli fisiologici, non per ansia di prestazione.
Implicazioni collettive
Quando la specie intera vive con basso tono enterocettivo, aumenta il ricorso a protesi esterne (stimoli, prestazioni, consumo), e diminuisce la capacità di autoregolarsi come ecosistema sociale. Per questo il lavoro sul corpo non è un affare privato: è infrastruttura della convivenza.
L’esercizio enterocettivo va quindi riconosciuto come competenza di base lungo tutto l’arco della vita (educazione, lavoro, cura), non come terapia opzionale per chi “sta male”.
Conclusione
La differenza fra sentire ed essere misura oggi il divario che separa l’umanità dalla propria fisiologia. Colmare quel divario significa restituire priorità biologica al corpo: non per negare la mente, ma per rimetterla al suo posto, come funzione al servizio della vita.
Solo così l’allenamento enterocettivo potrà trasformarsi in direzione stabile: dal gesto tecnico allo stato identitario, dal beneficio individuale a un patto etico con la specie e con il mondo che la ospita.
Nota 1. Enterocezione.
Enterocezione – È il senso che consente di percepire gli stimoli interni al corpo (respiro, battito, tensioni viscerali, equilibrio autonomico). Le principali vie neurofisiologiche convergono nella corteccia insulare, che integra percezione corporea, emozioni e coscienza. Studi recenti mostrano come una carenza enterocettiva sia correlata a disturbi d’ansia, depressione, disordini alimentari e patologie croniche.
Nota 2. Codice Bipolare.
Definizione adottata in BioMAGIA – Principio fisiologico che regola i cicli opposti e complementari del corpo (attivazione/riposo, tensione/distensione, espansione/ritiro). La perdita di questo ritmo naturale porta a squilibri sistemici e facilita la comparsa di tensioni croniche, rigidità e sintomi psicosomatici.
Nota 3. Normalità apparente.
In medicina sociale si parla di “morbosità occulta” per descrivere la quota di sofferenza non diagnosticata che la popolazione considera normale. Allo stesso modo, in psicologia clinica, molte forme di tensione, ansia o dolore cronico non vengono percepite come patologiche ma come parte inevitabile della vita. Questo bias collettivo impedisce di riconoscere la disfunzione enterocettiva come problema universale della specie.
Nota 4. Paura del giudizio.
La ricerca psicologica conferma che i meccanismi di adattamento sociale (soprattutto in età infantile) attivano circuiti di inibizione emotiva. Questo processo riduce progressivamente la capacità di sentire gli stati interni, sostituendoli con comportamenti di conformità. Nell’adulto, il “ritorno al sentire” spesso rievoca la stessa paura, che diventa soglia critica del percorso enterocettivo.